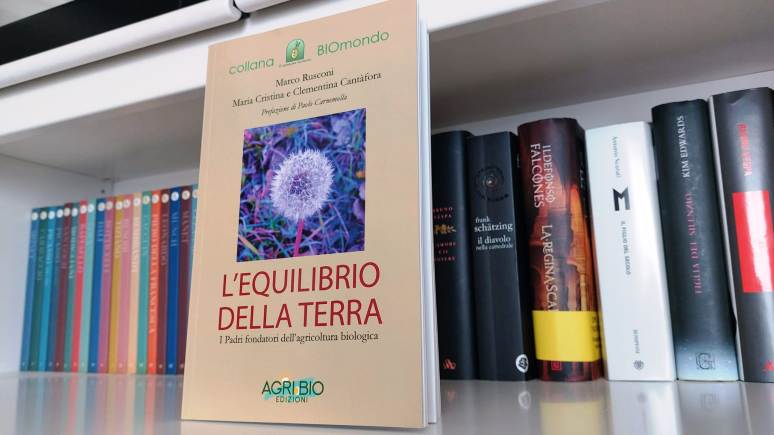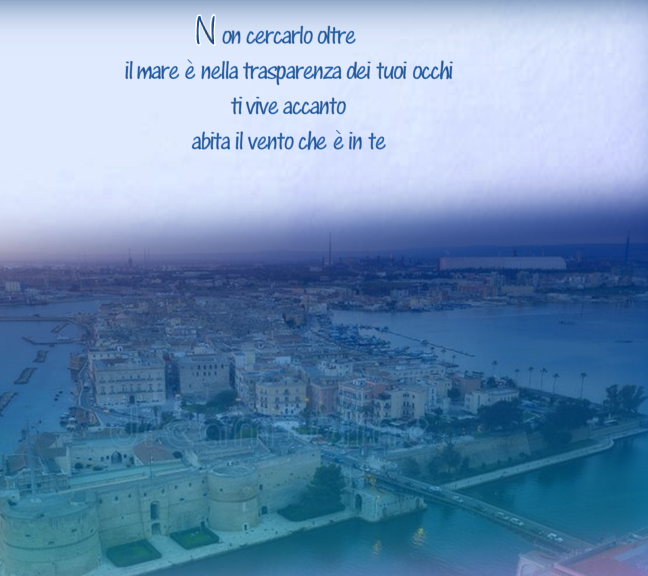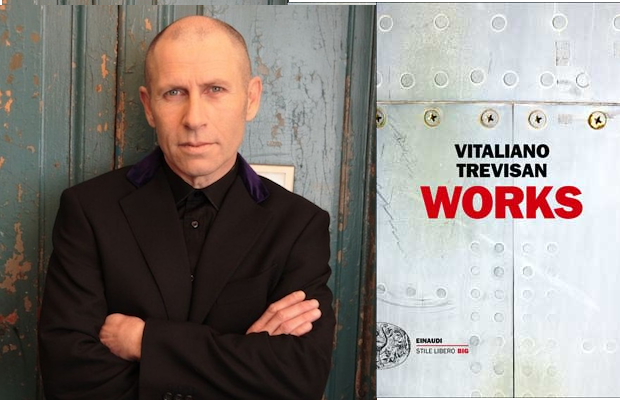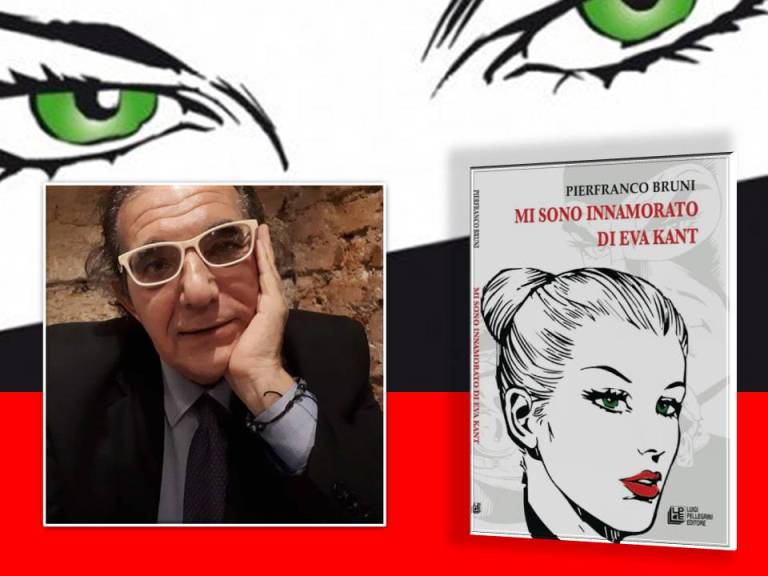L’illuminante armonia del silenzio montaliano
di Stefania ROMITO
“Ossi di seppia ” allude alla presenza del mare che sarà cantato in “Mediterraneo”, una serie di liriche nelle quali il mare sarà guardato nella sua diversità, invidiato per la sua capacità di essere vasto, diverso e insieme fisso, capace di svuotarsi di ogni lordura (“come tu fai, che sbatti sulle sponde, tra sugheri e arterie, macerie del tuo abisso”). Fra queste macerie ci sono gli ossi di seppia che vengono trasportati dalle onde come cosa inutile. Montale qui stabilisce un curioso parallelo tra le cose inutili e le cose utili.
Questa concezione poco romantica viene sostenuta in un testo diventato famoso per contenere l’essenza della poetica di Montale: “I limoni” (“Ascoltami, i poeti laureati si muovono soltanto fra le piante dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti”). In questa affermazione indicativa si stabilisce subito una opposizione. I poeti laureati usano riferirsi solo a piante da giardino, piante letterarie che si conoscono poco ma che vengono nominate perché fanno riferimento ad una realtà preziosa, ma poi vi sono “le strade che riescono agli erbosi”, strade fatte da nessuno, sentieri che vengono praticati in libertà, dove non c’è una natura curata, bensì una natura allo stato brado.
“Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi che sboccano”. I poeti laureati non userebbero mai l’espressione “io per me amo le strade”, sprezzatura linguistica tipica del parlato che abbassa il livello stilistico della poesia a quello normale della conversazione a sottolineare la differenza che si vuole stabilire rispetto alle abitudini di una certa letteratura.
Gli alberi di limoni sono parte integrante di una realtà quotidiana, proprio perché siamo in Liguria. Si tratta di un tipo di frutto che necessita del sole e non cresce dappertutto. In questa terra è qualcosa di comune, ed è per questo che Montale lo sceglie come emblema di ciò che vuole raccontare, oltre che per il colore che splende in mezzo a una natura desolata.
“Le viuzze che seguono i ciglioni, i soli sentieri e improvvisamente discendono tra i ciuffi delle canne”. Dominano le immagini naturalistiche. Questi piccoli orti, tipici della Liguria, sono comuni fra le case e appaiono inaspettati tra le case e il terreno. Luoghi che appaiono all’improvviso alla vista di colui che sta passeggiando in mezzo alle “cose normali” dell’esistenza. Alla vista di questi orti, che rappresentano piccole pause rispetto a tutto il resto, Montale sottolinea la presenza di un silenzio, di una pace rispetto allo scorrere della vita: “Qui nelle divertite passioni per miracolo tace la guerra qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è l’odore dei limoni”. In presenza di questo paesaggio naturale tace la guerra delle passioni. In questi luoghi lontano dai traffici e dai commerci umani, la natura si può presentare in tutta la sua bellezza, “qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza, ed è l’odore dei limoni…”.
“Noi poveri”, viene sottolineato in opposizione a quei “poeti laureati” che cantano le grandi passioni, la guerra della cose, i poeti che si fanno vati di una società e di una nazione. Qui, invece, dove tutto è tranquillo, dove sembra di poter tornare all’interno della naturalità del Creato, anche noi poveri che non ci riconosciamo in quello stato di cose e in quella guerra, possiamo godere della nostra parte di ricchezza (tranquillità) simboleggiata dall’odore dei limoni.
“Vedi. In questi silenzi in cui le cose s’abbandonano e sembran vicine a tradire l’ultimo segreto, talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di Natura il punto morto del mondo, l’anello che non tiene il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità”. In questi versi, che costituiscono il cuore della poesia, il poeta spiega cosa trova di tanto interessante nei luoghi in cui crescono gli alberi di limoni. Versi che rappresentano una sorta di “rottura” nell’ordine normale delle cose. Elemento estraneo di qualcosa che appare per “caso”, o per miracolo, in mezzo alla confusione ordinaria del mondo. Un luogo privilegiato in cui è possibile cogliere la verità. Verità che viene colta attraverso un filo da disbrogliare, nell’intrecciata matassa delle cose, il bandolo che ci permette di arrivare al dunque. La verità è recepibile solo attraverso la casualità, lo sbaglio di natura. Perché questi orti chiusi, nei quali normalmente non ci si accede, rappresentano qualcosa di estraneo al mondo, un qualche cosa in cui si giunge per caso in grado di illuminare il nostro cammino esistenziale.
Giungere in questi luoghi, godere di queste immagini che ci balzano agli occhi, ci facilita a spingere il nostro sguardo al di là dell’apparenza delle cose. È questo sguardo che liberamente vaga, i nostri sensi resi più attenti, a cogliere qualche cosa del segreto della natura. Siamo all’interno delle corrispondenze baudelairiane. Non c’è niente di preciso. La mente indaga, accorda, disunisce. Si muove liberamente e stabilisce confronti, paralleli, connessioni che altrimenti non sapremmo stabilire. A ciò aiuta il profumo che dilaga, la situazione del giorno che languisce. Questa tranquillità in cui ci si trova immersi e in questi silenzi (in ogni ombra umana che si allontana), pare di cogliere qualche disturbata divinità. Le eventuali apparizioni sembrano segnalare qualcosa di misterioso e miracoloso.
Questi aspetti, di cui normalmente non ci accorgiamo, ci illuminano su qualche significato che potrebbero avere e che di solito non ce ne curiamo. La nostra disposizione è facilitata dal trovarci in questo luogo, che ci permette di intendere i segnali misteriosi della natura in una fusione panteistica che è essenza esistenziale.
(Pubblicato su oraquadra.info) – SOSTIENI IL BLOG